Un vecchio proverbio dei paesi anglofoni dice:
“One man’s trash is another man’s tresure”, cioè quello che per qualcuno è
spazzatura, per altri è un tesoro. Da quando si è trasferito a New York, l’artista
tedesco Lothar Osterburg sembra aver fatto di questo detto il suo motto,
raccogliendo materiale di scarto che accumula nel suo studio per creare le
sculture e le scenografie alla base delle sue opere.
“Il laboratorio è pieno di roba in attesa
di essere riciclata”, dice Osterburg rovistando fra scaffali traboccanti di
oggetti trovati per strada.
Lo spazio in cui lavora in un’ex fabbrica
di Brooklyn è un luogo a metà strada fra la bottega dell’artigiano, il deposito
del robivecchi e l’atelier dell’artista: le opere finali prodotte da Osterburg
sono heliogravure, sofisticate fotoincisioni ottenute con una tecnica inventata
nell’Ottocento. Prima di arrivare a creare le stampe però, l’artista tedesco
cura personalmente tutto il processo, costruendo, fotografando, incidendo e
stampando le immagini su carta. Da solo, senza l’aiuto di assistenti, questo
incisore-scultore arriva a produrre solo poche immagini all’anno. Ma è contento
così.
“Mi considero un po’ come un artista
rinascimentale”, ammette Osterburg in un inglese che tradisce ancora le origini
teutoniche, nonostante viva negli Stati Uniti da più di venticinque anni.
“Voglio avere il pieno controllo del processo creativo. Per questo amo fare
tutto con le mie mani”.
Così il tappo di metallo di un vasetto da
conserva diventa la ruota di un carro, le pagine di un’enciclopedia si
trasformano in vagoni della metropolitana, gli stuzzicadenti in pali della
luce. I dettagli sono spesso sfumati e le forme bizzarre degli oggetti
ritrovati lo aiutano a infondere vita alle immagini.
 |
| In preparazione di Zenobia |
“Qualsiasi paesaggio contiene forme che la
nostra mente non riesce a identificare, come lo sporco accumulato lungo la
strada. Noi tendiamo a ricordare solo ciò che riconosciamo. Ma sono proprio i
dettagli sconosciuti a dare carattere ai ricordi”.
I suoi modellini riproducono spesso
strutture architettoniche in scala ridotta. E le stampe finali hanno un tratto
onirico, con l’uso di sfuocati e l’obiettivo fotografico sistemato nel mezzo
della scena, come a rappresentare il punto di vista di un passante. La
prospettiva che ne risulta è sfalsata e maschera le proporzioni reali, creando
un mondo fiabesco.
“Questa tecnica funziona bene con temi
nostalgici, fantasie di mondi sospesi fra passato e futuro”, sottolinea
l’artista cinquantenne, titolare di una borsa di studio della Guggenheim
Foundation.
I paesaggi di una New York fatta di
traffico e viadotti, le città invisibili immaginate da Italo Calvino nel libro
omonimo, le architetture fantastiche delle Carceri di Giambattista Piranesi
sono fra le fonti da cui Osterburg trae ispirazione. I suoi modellini sono vere
e proprie scenografie e spesso l’artista le sfrutta per realizzare video, come
quello che presenterà questo mese a New York, nato da una collaborazione con la
moglie, la compositrice Elizabeth Brown, e intitolato A Bookmobile for Dreamers. Anche i libri sono una presenza
ricorrente nelle sue opere (l’ultima mostra tenuta a New York a febbraio
s’intitolava Library Dreams and
Yesterday’s City of Tomorrow).
“Sono affascinato dai libri, perché
rappresentano un’idea di scoperta che va scomparendo. Oggi i computer e la
tecnologia ci permettono, in teoria, di farne a meno. Senza i libri, però, si
perde parte del piacere e della sorpresa legati alla scoperta”.
In un’epoca in cui sempre più spesso gli
artisti si affermano solo grazie alle loro idee, lasciando la realizzazione
delle opere a stuoli di assistenti, Osterburg è una mosca bianca.
“Mi piace occuparmi di tutto il processo
per realizzare un’opera. Più che la meta finale, m’interessa il percorso
intrapreso per raggiungerla”.
Anche per questo l’artista ha sempre
preferito concentrasi su oggetti di propria creazione, invece che trovare
modelli reali o già esistenti.
E dire che da giovane i suoi insegnati lo
avevano definito pigro. Dopo il liceo, Osterburg sognava di iscriversi al
conservatorio. Allora suonava il contrabbasso e voleva diventare musicista.
Subito prima della fine della scuola, però, il suo insegnante di musica aveva
convocato i genitori per consigliargli di far cambiare idea al figlio. A suo
parere il ragazzo non si applicava abbastanza ed era chiaro che non sarebbe
arrivato mai lontano nel mondo della musica. “Al momento fu un duro colpo da
digerire, ma poi si rivelò la cosa migliore che potesse capitarmi”.
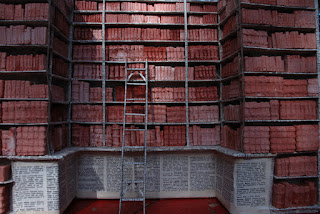 |
| Modellino di preparazione per Bookmobile for Dreamars |
Abbandonata l’idea del conservatorio, Osterburg
decide di iscriversi a una scuola d’arte dove comincia ad interessarsi di
incisioni e fotografia.
“Finalmente capì cosa significa perdere il
senso del tempo e lasciarsi completamente assorbire da quello che si sta
facendo”, ricorda. “Un’esperienza che non mi era mai successa in tutti le ore
passate a esercitarmi suonando”.
Poco dopo la fine dell’università, vince
una borsa di studio per San Francisco e lì comincia a lavorare realizzando
stampe e incisioni per altri artisti.
“Il printmaker è il gradino più basso
nella categoria dell’artista. Molti considerano questo lavoro solo come
un’attività artigianale”.
All’inizio degli anni Novanta, l’artista
francese Christian Boltanski gli chiede di realizzare delle stampe con la
tecnica della heliogravure, o fotocalcografia al bitume, considerata il più complesso
dei procedimenti fotomeccanici derivati dalla sperimentazione fotografica di
fine Ottocento. Questa tecnica consiste nel riportare un’immagine fotografica
su una lastra di rame preparata con acidi, per poi trasferirla su carta. La
heliogravure è stata in voga fino ai primi anni del Novecento, ma oggi sono
rimasti in pochissimi ad utilizzarla. L’esecuzione è laboriosa, ma il risultato
è di grande impatto visivo, con toni morbidi e vellutati. Da allora Osterburg
si è specializzato in questa tecnica e ha prodotto un vasto repertorio
d’immagini dalle atmosfere surreali e grottesche che richiamano le opere di
Piranesi.
“Mi sono sempre identificato molto con
l’artista italiano”, conferma Osterburg. “Siamo entrambi incisori e per anni
anche lui fu costretto a guadagnarsi da vivere stampando opere d’altri”.
Un altro aspetto che accomuna i due
artisti, è la tendenza a ritornare sulle proprie opere nel tempo. Piranesi
modificò più volte le lastre delle Carceri. Anche Osterburg spesso rimette mano
ai modelli e alle sculture che ha già fotografato per realizzare nuove
composizioni. Oppure, dopo aver stampato una lastra, ritorna a inciderla col
bulino per ricavarne immagini differenti.
“Tendo a pensare che le mie opere siano in
continua evoluzione. Essendo interessato al percorso più che al traguardo, mi
piace l’idea di estendere il viaggio all’infinito”.

Nessun commento:
Posta un commento