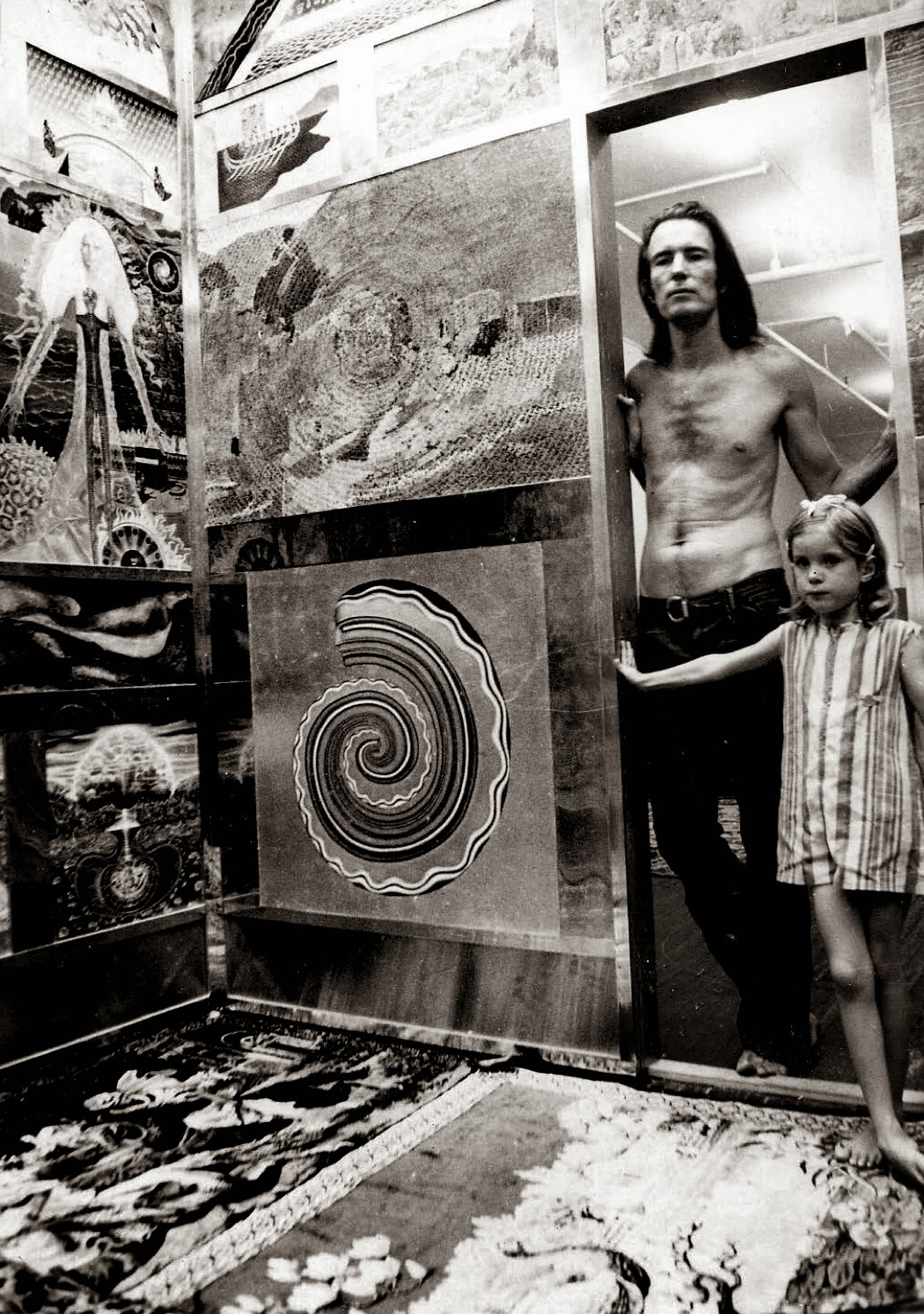 | |||
| Klarwein and his daughter inside the Aleph Photo by Caterine Milinaire |
“Sono il più famoso fra gli artisti sconosciuti”,
ripeteva spesso ironico Mati Klarwein. I quadri del pittore tedesco scomparso
nel 2002 sono apparsi sulle copertine di alcuni degli album più venduti degli
anni Settanta: Abraxas di Carlos Santana, Bitches Brew di Miles Davis e Last
Days and Time degli Earth, Wind&Fire. Gente come Jimi Hendrix, Jackie
Kennedy e Brigitte Bardot erano suoi ammiratori. Ma fra il grande pubblico il
suo nome resta quasi sconosciuto. Così come il suo capolavoro più rappresentativo,
l’Aleph Sanctuary, una stanza con pareti e soffitto composti da 68 quadri fatti
dal pittore nel corso di 10 anni.
Klarwein nasce ad Amburgo nel 1932 da
padre ebreo polacco e madre cattolica tedesca. Con l’avvento delle leggi
razziali naziste si trasferisce a Gerusalemme, ma poco dopo lo scoppio del
conflitto arabo-israeliano, rientra in Europa per studiare all’Accademia delle
Belle Arti di Parigi e poi con Fernand Léger. Questa formazione classica gli
permette di cominciare a lavorare come ritrattista. Ma è l’incontro con il
pittore austriaco Ernst Fuchs, che lo introduce al surrealismo di Dalì e
Buñuel, a incendiare la creatività di Klarwein.
Tanto che, quando si trasferisce a New York a metà degli anni Sessanta, il pittore comincia a realizzare i quadri visionari e coloratissimi che lo trasformano in uno dei principali punti di riferimento per l’arte psichedelica. E’ qui che dipinge le grandi tele che compongono l’ossatura della sua installazione più memorabile, l’Aleph Sanctuary.
Tanto che, quando si trasferisce a New York a metà degli anni Sessanta, il pittore comincia a realizzare i quadri visionari e coloratissimi che lo trasformano in uno dei principali punti di riferimento per l’arte psichedelica. E’ qui che dipinge le grandi tele che compongono l’ossatura della sua installazione più memorabile, l’Aleph Sanctuary.
Questi quadri sono ispirati a passaggi
biblici, arricchiti da abbondanti riferimenti sessuali: Crucifixion (1963-65) è
un albero formato da un groviglio corpi copulanti; Nativity (1962) mescola
simbologie di religioni orientali con donne nude e funghi atomici; Grain of
Sand (1963-65) è un pantheon provocante dei personaggi più disparati: da Ganesh
a Marilyn Monroe, da Ray Charles a Socrate.
 |
| Inside the Aleph Sanctuary, courtesy of Mati Klarwein Legacy |
Inizialmente Klarwein cerca senza successo
di vendere le tele singolarmente. Finché un giorno decide di assemblarle per
creare un’installazione all’interno del suo studio-loft sulla 17esima Strada.
Ai tempi il pubblico era abituato a vedere opere appese alle pareti e l’idea di
creare una stanza fatta di quadri è piuttosto rivoluzionaria.
“Voglio divenire un catalizzatore del
divino e il modo migliore per cominciare è costruire uno spazio concentrato, un
santuario. Ho deciso di creare un cubo di tre metri che chiamerò l’Aleph
Sanctuary”, racconta Klarwein nel suo libro Collected Works. “Creare un tempio
è difficile, un po’ come partorire e rifarsi il naso nello stesso giorno, ma
come Eichmann io non posso far altro che obbedire agli ordini del nostro Fuhrer
universale che siede sul suo trono dorato”, aggiunge ironico.
Klarwein è spirituale ma non religioso nel
senso classico del termine. Le esperienze in Germania e Palestina gli hanno
insegnato a diffidare degli estremismi, spingendolo ad aggiungere al suo nome
quello musulmano di Abdul per sottolineare il bisogno di riconciliazione.
“Sono mezzo tedesco e mezzo ebreo, con
un’anima araba e un cuore africano”, scrive nel libro Improved Paitings.
Anche chi ha vissuto l’Aleph da vicino
ritrova una sorta di spiritualità ecumenica nell’opera del pittore.
“Lo chiamava santuario perché raccoglieva
la sua arte migliore ed era un luogo di raccoglimento dove aprire la mente”,
ricorda Caterine Milinaire, compagna di Klarwein nel periodo in cui l’Aleph
dominava il suo atelier, attirando gente come Jimi Hendrix e Timothy Leary a
meditare al suo interno.
Klarwein non ha mai fatto segreto della
sua passione per le droghe psichedeliche e certo entrare nell’Aleph in acido
deve essere stata un’esperienza unica.
“Era come avere davanti agli occhi una
costante esplosione di fuochi d’artificio”, ricorda Milinaire, che passò un
inverno dormendo con Klarwein nell’Aleph perché il resto del loft era troppo
freddo. “Era un posto fantastico per sognare”.
Ma l’idea di costruire un tempio ha anche
un significato personale per l’artista. Il padre architetto fu l’autore della
Knesset, il parlamento israeliano a Gerusalemme.
 |
| Plexiglass reproduction (1990s), courtesy of Mati Klarwein Legacy |
“L’unica cosa che potevo fare per
superarlo era costruire qualcosa di più grande, un nuovo tempio di
Gerusalemme”, scrive l’artista.
L’Aleph è smontabile ed è concepito come
una struttura nomade, quasi a ricalcare la biografia del suo autore, che ha
viaggiato in tutto il mondo e vissuto in almeno cinque paesi diversi,
trascorrendo gli ultimi anni della sua vita nell’isola di Maiorca.
La prima volta che si sposta da New York,
l’Aleph è spedito all’Università del Colorado nel 1971, dove gli studenti si
autotassano per installarlo nell’ateneo. Lì è notato da un curatore che decide
esporlo nel museo di Santa Barbara. Ai tempi la città californiana era molto
conservatrice e l’arrivo dell’opera crea scalpore, costringendo il direttore
del museo a mettere una guardia all’ingresso e proibire l’entrata ai minori.
L'Aleph torna poi a New York, dove viene ospitato in uno spazio sulla 77esima
strada, a un passo dalla mitica galleria di Leo Castelli. A quel punto ha
acquisito una certa fama fra gli esperti e sono molte le gallerie che
vorrebbero esporlo. Klarwein, però, si trova in ristrettezze economiche ed è
costretto a vendere alcuni dei quadri che lo compongono. Per un periodo i
collezionisti lasciano che i loro quadri viaggino con l’Aleph, ma verso la fine
degli anni Settanta lo costringono a smontarlo. E’ un momento triste, ma
Klarwein lo prende con filosofia.
“Anche se il tempio è stato smontato e
venduto a pezzi, continuerà a vivere nella memoria di quelli che l’hanno
visto”, scrive nel 1988.
Pochi anni, però, davanti alla possibilità
di ricostruire il santuario con riproduzioni in plexiglass tratte dalle foto
dell’originale, l’artista non esita. L’opera torna così a girare ed è esposta
in alcuni musei famosi, come la Tate di Liverpool e il Whitney di New York.
Certo non ha lo stesso impatto
dell’originale dipinto a mano, ma chi ha visto entrambe le copie sostiene che
sia comunque un buon lavoro.
“La copia è stata realizzata bene”, dice
Milinaire. “E, a giudicare dalle code di visitatori che ho visto formarsi
davanti al suo ingresso, credo sia stato un esperimento di successo”.
Pubblicato su Casa Vogue
Nessun commento:
Posta un commento